
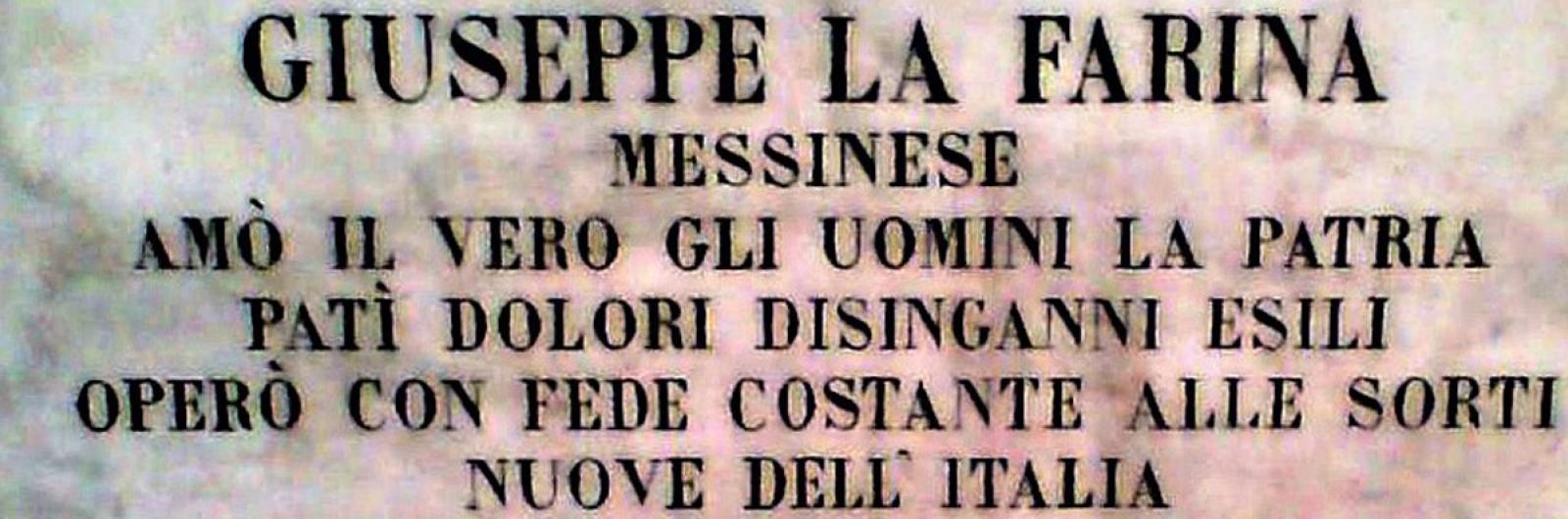
Un grande Patriota, Politico, Storico e Letterato messinese

Giuseppe La Farina fu onorato da Firenze con un monumento-cenotafio a lui dedicato nella Basilica di Santa Croce. Torino gli eresse una statua in piazza Solferino, opera di Michele Auteri-Pomar del 1884 e la Marina Militare Italiana diede il suo nome a un cacciatorpediniere.
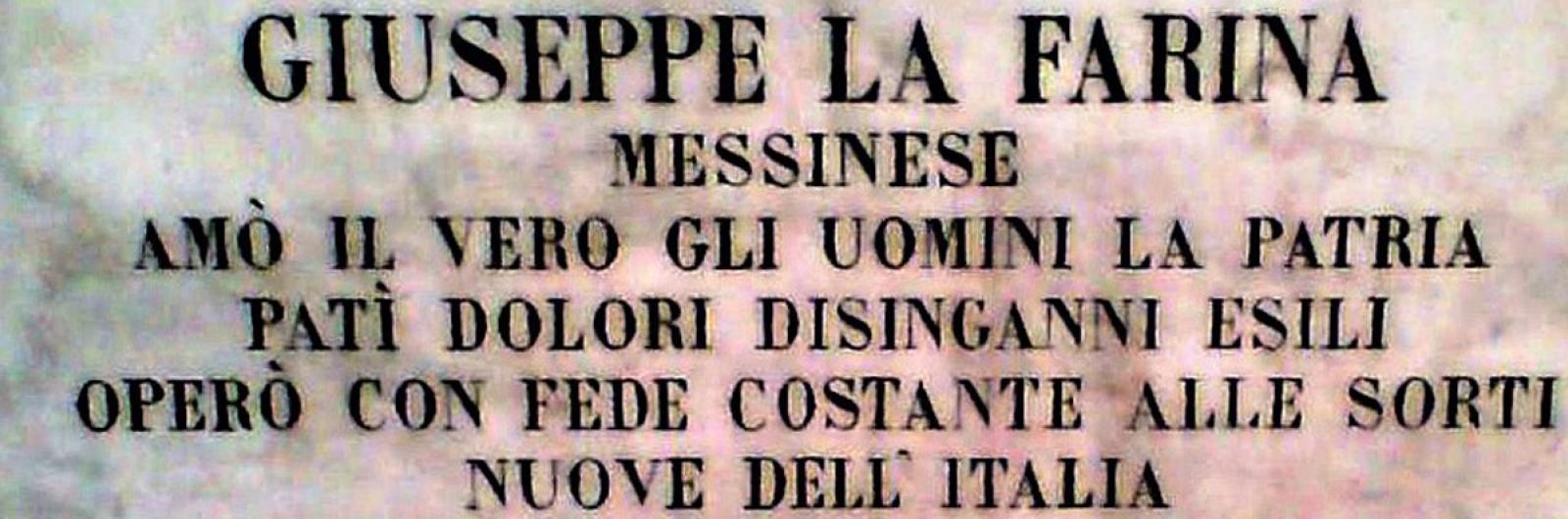
Nato il 20 luglio 1815, figlio di Carmelo La Farina, giudice della Gran Corte Criminale e fondatore e curatore del Museo Civico, a 11 anni si dedicò allo studio delle lingue straniere, lettere italiane, latine e greco. Dal 1826 al 1832 frequentò l’Accademia Carolina (elevata poi ad Università) per apprendere matematica, fisica, filosofia, chimica e anatomia. A tredici anni gli fu consentito di stare con il padre che nel 1828, per motivi politici, era stato rinchiuso nelle carceri di Palermo. Comprese, così, la sofferenza e le tribolazioni di chi si batte per un ideale che sarà la ragione più importante della sua vita. Ripresi gli studi, a diciassette anni si iscrisse al corso di Giurisprudenza e il 7 maggio 1835 si laureò all’università di Catania. Esercitò poco l’attività di avvocato e si dedicò agli studi storici e letterari pubblicando un gran numero di articoli, saggi, recensioni, racconti, poesie e scritti politici. Ma il suo interesse preminente era quello di portare aventi ideali liberali, di progresso e di redenzione della Patria. Idee che non abbandonerà mai fino alla morte che lo coglierà a Torino per apoplessia cerebrale, alla prematura età di 48 anni, il 5 settembre 1863.
Giuseppe La Farina venne sepolto a Torino fra le tombe di Vincenzo Gioberti e Guglielmo Pepe. Il 22 marzo 1872, le sue spoglie restituite dalla città di Torino, furono trasportate a Messina dove riposano nel Gran Camposanto, nel Famedio degli uomini illustri in un monumento realizzato da Gregorio Zappalà.
Dell'intensa attività letteraria di La Farina, vanno ricordati la guida “Messina ed i suoi Monumenti" (1840); "Studi storici sul secolo XIII" in due volumi monumentali (1842); “L’Italia coi suoi monumenti, le sue rimembranze, ed i suoi costumi" (1842); "Storia d'Italia narrata al popolo italiano. 568-1815" (1846-53); "La Storia d'Italia dal 1815 al 1850" (1851-52); "L'Italia dai tempi più antichi fino ai giorni nostri" (1856-63); “Discorso storico sulle rivoluzioni d'Italia dal 1791 ai nostri giorni” (1850); “Dei fatti più notevoli della Repubblica romana” (1857); “L'Italia con i suoi monumenti e le sue leggende” (1842); “La Svizzera storica e artistica” (1842-43). Collaborò anche con “L’amico delle donne”, periodico che si definiva “giornale d’amenità e d’istruzione” il cui primo numero uscì il 20 gennaio 1835. Allo stesso tempo La Farina diffuse il suo “Credo politico della Società nazionale italiana” e “La rivoluzione, la dittatura e le alleanze” (Torino 1859), un autentico manifesto programmatico di un'organizzazione da lui fondata insieme ad altri col proposito di affiancare fattivamente l'azione diplomatica di Cavour raccogliendo fondi e reclutando volontari da dirigere a Torino.
Accusato di partecipazione sovversiva al movimento rivoluzionario antiborbonico, nel 1837 è costretto a lasciare Messina per rifugiarsi a Firenze, spostandosi verso la fine dell'anno a Roma. Rientra nella sua città nel marzo del 1838 beneficiando di un'amnistia, ma i suoi mai sopiti ideali di libertà lo portano ad assumere la carica di rappresentante dei comitati segreti di Messina. Nell'agosto del 1841 ritorna a Firenze dove resterà fino al febbraio del 1848, per tornare lo stesso anno a Messina in piena rivolta antiborbonica, nominato vice presidente per il comitato di guerra ed eletto deputato nel nuovo Parlamento di Palermo. Il 24 settembre 1848 diviene ministro della Guerra e dopo il fallimento della rivolta isolana, riprende la via dell'esilio in Francia. Nel 1854, a Torino, incontra Cavour del quale diviene uno dei più fidati collaboratori e insieme a Daniele Manin e Giorgio Pallavicino Trivulzio, costituisce la “Società Nazionale Italiana” con lo scopo di realizzare l'idea annessionistica. Eletto, nel 1861, deputato al primo Parlamento italiano in ben sei collegi, accetta l'incarico di vice-presidente della Camera e partecipa anche attivamente ai lavori del Consiglio di Stato, di cui fa parte.
