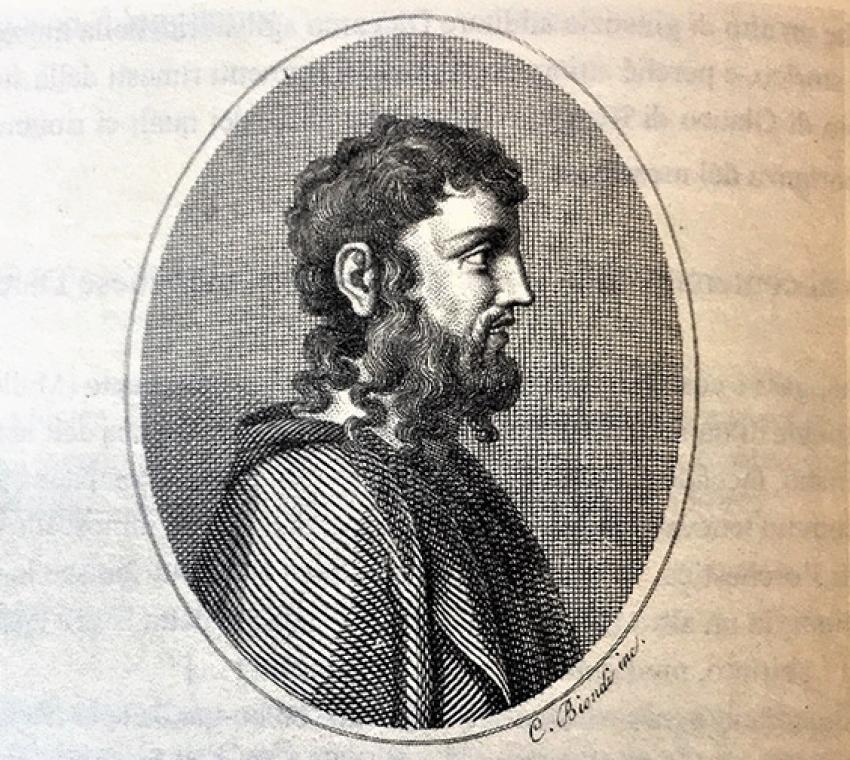

Il fondatore della cartografia scientifica
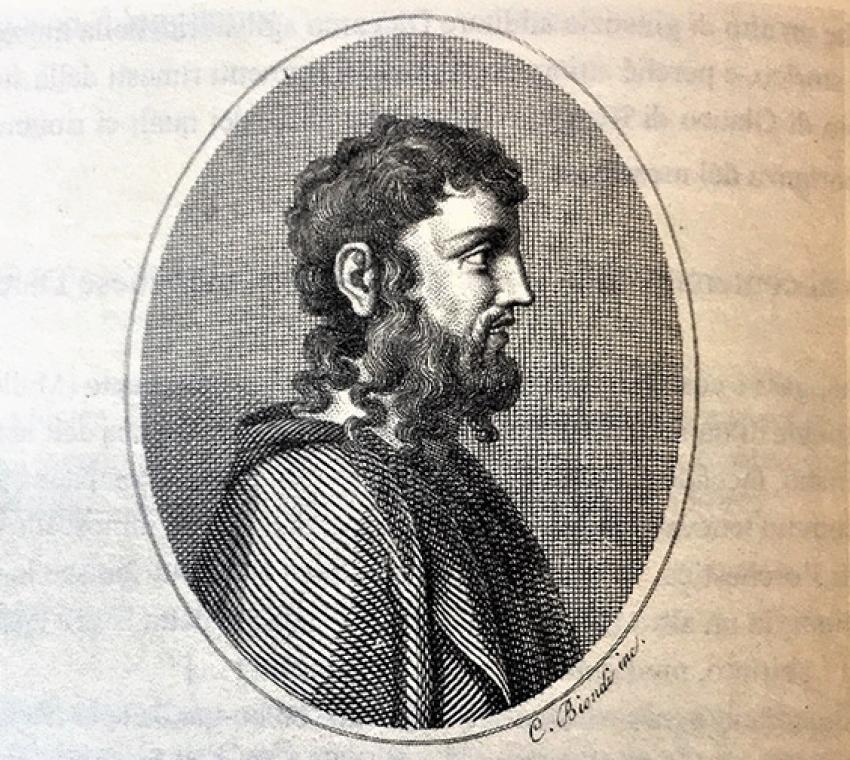
Dicearco da Messina fu un grande innovatore nel campo del pensiero filosofico. L’atteggiamento di carattere passivo e contemplativo verso la natura venne da lui sostituito da un modello attivo in cui è l’uomo ad essere responsabile della propria vita e del proprio destino: Il fato non esiste e la decadenza umana è solo frutto del cattivo uso che viene fatto della ragione. Come Teofrasto, fu esponente del vegetarianismo peripatetico e quindi gli animali vanno rispettati, così come gli uomini. Ma Dicearco fu un grande innovatore anche nel campo della cartografia…

Figlio di un certo Fidia, Dicearco nacque a Messana (Messina) nel 350 a.C. quando la città era dominata dai Mamertini. Viaggiò in Grecia per diverso tempo e, ancora giovanissimo, divenne discepolo di Aristotele nella famosa scuola peripatetica di Atene (il cui nome deriva dal fatto che Aristotele teneva le lezioni passeggiando con i suoi allievi nel “perìpato”, cioè sul lastricato in pietrame nel porticato interno del Liceo ateniese). Il suo pensiero, perciò, si allineò con quello della scuola peripatetica durata parecchio, dal IV sec. a.C. al VI sec. d.C. Dicearco si dedicò, così, allo studio della filosofia, storia, matematica, etica, costume, politica, geografia e della Mantica per la quale solo il sapiente può essere indovino. A Messana Dicearco diffuse l’aristotelismo peripatetico in un liceo da lui fondato, elaborando la teoria della conoscenza razionale basata sulla realtà dell’oggetto. In campo religioso fu però in contrasto con Aristotele, sostenendo che “[..]l’anima è forza vitale uguale per tutti gli esseri viventi, destinata a dissolversi dopo la morte”. In campo politico auspicò una trilogia amministrativa composta da aristocrazia, monarchia e democrazia. Morì nella sua Messana nel 290 a.C.
Dicearco da Messana raccontò per primo la fondazione di Napoli! Ecco cosa scrisse: “Nell’ inverno del primo anno della settantasettesima Olimpiade al cominciare del giorno […] noi cittadini e soldati di Cuma, sotto la guida del nobile e saggio Ileotimo, figlio di Timanore […] abbiamo risalito all’alba il sovrastante colle fino alla sua vetta, allo scopo di prendere gli auspici per la fondazione di una nuova città in un sito più ampio ed agevole di quello che chiamano Euploia, ove è ristretto l’abitato di Partenope”.
Delle opere di Dicearco rimangono pochi frammenti:
Vita della Grecia (Bios Hellados) in tre libri di cui restano 24 frammenti, una cronaca dall’antichità fino al regno di Filippo II. In alcuni brani Dicearco mette in risalto la dualità del progresso evidenziando come ogni scoperta, se da un lato risolve problemi, dall’altro ne genera altri. Molti frammenti sono dedicati alle origini della musica e della cultura della Grecia, con un attacco alla “musica moderna” dei suoi tempi.
L'anima muore con il corpo
Mantica
Vita pratica, dove sostiene la concretezza della vita pratica su quella teorica in antitesi con Aristotele.
Tripolitico – Dicearco divide tutti i governi in tre categorie, la democratica, aristocratica e monarchica, mirando a un governo "misto" dove tutte e tre le categorie hanno un ruolo nel governo della cosa pubblica.
Descrizione della Grecia - Frammento di un'opera dedicata a "Teofrasto", e composta da 150 trimetri giambici.
Itinerario intorno al mondo
Sui Monti del Peloponneso
Nell’opera Sui Monti del Peloponneso Dicearco tratta della misura dei monti con un sistema di triangolazione. Ebbe l’incarico di misurare i monti del Peloponneso e, secondo Plinio, fu proprio da lui che si seppe per la prima volta nella storia che il Pelione era alto 1250 passi (il Pelione o monte Pelio è una montagna a sud est della Tessaglia, nella Grecia centrale. Nella mitologia greca era la terra di origine di Chirone il centauro, protettore di diversi eroi greci come Achille, Eracle, Teseo e Giasone). Diede anche per primo la misura della circonferenza della Terra. Ma l’innovazione cartografica e geografica più importante di Dicearco fu nell’altra sua opera Itinerario intorno al mondo: adottò le coordinate geografiche longitudine e latitudine, sistema che in breve divenne il metodo usato dai geografi alessandrini. Per primo quindi suddivise la Terra in meridiani e paralleli, con un parallelo di riferimento che passava e individuava qualunque punto nella stessa latitudine delle terre allora conosciute, dalle Colonne d’Ercole al Caucaso indiano. Dicearco dunque, anticipando Eratostene, fu l’inventore dei nostri, attuali meridiani e paralleli. E il parallelo maggiore lo fece passare proprio dalla sua città natale, Messina. E non poteva essere diversamente!
